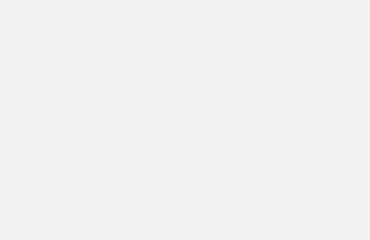Ha avuto giusta risonanza il documento diffuso dalle accademie della Crusca e dei Lincei sull’insegnamento della lingua italiana, che i giovani conoscono malissimo. Ma uno dei fatti che denunciano la crisi mi pare la mancanza di selettività riguardo ai cosiddetti registri. Questa parola, che i linguisti moderni hanno tratto dalla terminologia musicale, indica tutte le varietà di una lingua, impiegate a seconda del livello culturale e sociale dell’interlocutore e del tipo di situazione.
Si parla di registro aulico, colto, medio, colloquiale, familiare, popolare, ecc. Sappiamo che ci si esprime diversamente parlando a un re o a uno straccivendolo, in un’assemblea o all’osteria, a un superiore o a un compagno di bisbocce; o anche a un vecchio o a un bambino. Cambia la scelta delle parole: sventurato, sfortunato, scalognato, iellato, sfigato hanno, più o meno, lo stesso significato, ma appartengono a registri diversi. Cambia la sintassi: nel Nord il passato remoto si usa solo nei registri più alti, e l’indicativo tende a sostituire il congiuntivo; gli per «a lei» è condannato, ma usato a livello colloquiale; i dialettalismi, che insaporiscono la lingua, sono inopportuni ai livelli alti. Chi non sa usare i registri crea situazioni d’imbarazzo, e può persino offendere, quasi ricusasse le differenze tra le categorie e le funzioni sociali. Certo, si può far violenza ai registri per polemica o per esibizionismo, ma anche in quel caso occorre conoscerli; non ci si può certo appellare allo stile postmoderno, che ha già portato più equivoci che chiarimenti. I giovani sono quelli che sembrano ignorare di più i registri, e con ciò stesso si mettono in condizione d’inferiorità, perché mostrano di non aver rilevato, nel parlare, che la scelta linguistica denota la loro attitudine a posizionarsi rispetto ai propri simili, e a riconoscere il ruolo o i meriti degli interlocutori.
Il rispetto dei registri è uno di quegli atti di cortesia che rendono più scorrevoli i rapporti umani. L’individuazione dei registri è particolarmente difficile per gli stranieri, che possono anche parlare bene la nostra lingua ma non si accorgono delle stonature prodotte da interferenze tra questi: per esempio usando termini del gergo giovanile in un discorso scientifico. Si dovrebbe dunque essere pazienti quando un «vu cumprà» ci interpella col tu, ma chi gl’insegna la lingua dovrebbe fargli rilevare l’imprecisione, e soprattutto evitare di interpellarlo allo stesso modo, denunciando il proprio senso di superiorità. La nostra classe politica, che in tempi lontani annoverava ottimi parlatori e oratori, tende sempre più ad abbassare il registro, perché pensa di conquistare più facilmente il consenso ponendosi a un livello meno elevato. È la tentazione, strisciante, del populismo. Naturalmente questo implica il degrado anche delle argomentazioni, perché, ai livelli alti, il linguaggio è molto più ricco e duttile. Le conseguenze sono disastrose: da una parte si finisce per ridurre qualunque dibattito a uno scontro fra slogan contrapposti, dall’altra si favorisce la trasformazione di contrasti d’opinione in alterchi, nei quali le passioni, o i preconcetti, annullano il confronto delle idee.
Non si tiene conto del fatto che la capacità di usare il registro alto (pensiamo ai discorsi, perfetti per strategia argomentativa, dei Kennedy, dei Clinton e degli Obama) è uno degli elementi che contribuiscono alla «maestà», poca o tanta, di un personaggio politico. Il quale, mettendosi invece al livello dell’ascoltatore medio, sarà magari guardato con simpatia, ma perderà qualunque aura: cosa che alla lunga può provocare perdita di autorità. Uno degli elementi costitutivi dei registri più bassi è il turpiloquio. Purtroppo il pessimo costume di abbandonarsi al turpiloquio (a partire dal «me ne frego» fascista) si sta diffondendo ovunque, molto meno disapprovato della diffusione degli anglismi, che se non altro non feriscono il buon gusto. Forse si teme che questa disapprovazione sia considerata bacchettoneria; si dovrebbe invece formulare una condanna esclusivamente estetica. Anche qui, molti giovani si mettono alla testa del peggioramento. Pensiamo all’uso di punteggiare qualunque discorso con invocazioni al fallo maschile, naturalmente nel registro più basso, che inizia con la c. Un marziano giunto tra noi penserebbe che il fallo sia la nostra divinità, tanto ripetutamente viene nominato dai parlanti. Insomma, una vera fallolatria.
Ma la celebrazione del fallo viene poi alternata con quella dell’organo femminile, o con allusioni ad atti sessuali più o meno riprovati, con auguri agli avversari di subire trattamenti sessuali sgradevoli, e così via. È vero che la fantasia ormai scarseggia; ma se qualche utente del registro fallico, riscuotendosi da un uso meccanico delle espressioni, badasse al significato letterale delle parole, si accorgerebbe che il suo orizzonte è ormai dominato da organi sessuali maschili e femminili, da scene di stupro e di sodomia e simili. Un po’ di varietà, per favore! Anche questo malcostume è condiviso da molti nostri politici, vogliosi di celebrare la propria virilità; dovrebbero leggersi o rileggersi Eros e Priapo di Gadda. Non si può reagire col sorriso, quando si rifletta che richiamarsi ai fondamentali della nostra animalità, alla vitalità prepotente e incontrollabile del sesso, ci porta agli antipodi non solo della ragione e degli ideali, ma anche della razionalità e della capacità dialettica che dovrebbero contraddistinguere l’homo sapiens sapiens. E non dimentichiamo che i cosiddetti attributi, se da un lato vengono usati a designare vigore e potenza, dall’altro sono sinonimo di stupidità: una molteplicità di significati che ci porta nell’indifferenziato, là dove la parola non è ancora stata affilata per interpretare il mondo.
autore: Cesare Segre
fonte: Corriere della sera