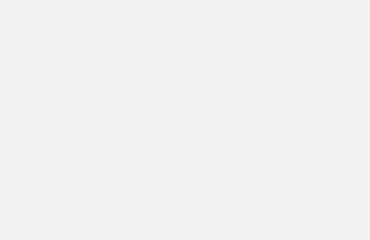di Fabio Chiusi
Al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia Luca De Biase, direttore di Nòva24, offre nel suo keynote speech uno sguardo originale e, soprattutto, carico di fondata speranza sul futuro del giornalismo: che invece di dettare univocamente legge dovrà «fare di tutto per farsi adottare del pubblico»; che vedrà sostituirsi un modello quasi “fordista” della produzione dei contenuti (il quotidiano decide che cosa far dire a chi e lo vende ai lettori) con un vero e proprio “ecosistema dell’informazione”, in cui redazioni e cittadini finiranno per far parte di una gigantesca “intelligenza collettiva” chiamata Rete. I primi – notevoli – risultati si stanno già vedendo, ad esempio in forme di “inchiesta on demand” come quella che è valsa il Pulitzer a ProPublica. Di questo e altro parliamo con lo stesso De Biase, raggiunto subito dopo il suo discorso al teatro Pavone.
Durante il suo intervento lei ha detto che il Pulitzer a ProPublica non è stato un premio a un sito web ma a «un’inchiesta finanziata da comuni cittadini in cui il denaro è del tutto strumentale a ciò che la società vuole sapere». Secondo lei è possibile che una iniziativa analoga abbia successo in Italia o c’è una differenza culturale tra noi e gli Stati Uniti nella percezione che i cittadini hanno del giornalismo e del suo ruolo che lo impedisce?
Tecnicamente le donazioni negli Stati Uniti sono detassate e questo rende molto più ampio il mondo del no profit sotto il punto di vista giornalistico. Ma aldilà del fatto tecnico la sua domanda è sulla disponibilità culturale. Teniamo presente che l’Italia è il paese in Europa con il massimo impegno nel volontariato, è un paese che quando c’è bisogno è generoso – e lo dimostra in tutte le occasioni di emergenza. Quello che non ha mai avuto l’occasione di fare è organizzarsi per donare a progetti di ricerca che servano la società, anche perché non c’è mai stata una vera discussione sul ruolo di ricerca giornalistica. E dunque da questo punto di vista non abbiamo la controprova. Abbiamo soltanto l’idea che c’è un buon potenziale.
Sempre oggi ha sottolineato che più che una crisi irreversibile dell’editoria questo periodo stia testimoniando una “esplosione di speranza”. Dall’altro lato lei stesso sottolinea come il bene scarso, e dunque il valore, oggi risieda nel tempo e nell’attenzione del pubblico, sempre più sommerso dal flusso costante dell’informazione. È dunque di un modello di business che tenga insieme queste due istanze – molteplicità degli stimoli e disponibilità limitata di tempo e attenzione – che il giornalismo ha bisogno per sopravvivere nell’era digitale?
Combattere per l’attenzione e il tempo del pubblico lo si può fare in due modi: o urlando di più, invadendo di più il tempo del pubblico, oppure servendolo e dimostrando di essere “adottabile” nella conversazione che il tempo svolge. È questa la sfida. È chiaro che chi punterà a urlare di più contribuirà alla scarsità di attenzione e a una difficoltà di dibattito ragionevole, pacifico. Ci saranno tutte e due le strategie, il problema è noi a quale vogliamo dare il nostro contributo.
Lei ha anche parlato di “intelligenza collettiva”. Un termine che a certi “guru convertiti” della Rete non piace. Che ne pensa di chi come Lanier e Carr sostiene che questa “esplosione di speranze” rischi concretamente di rendere gli utenti della Rete più superficiali, meno creativi e in definitiva meno “persone”?
È un pericolo vero, assolutamente importante. Il fondamentalismo digitale è stato l’oggetto della critica di un libro che ho scritto: è chiaro che non si può dare alla tecnologia e alle opportunità che offre il compito di salvare il mondo. Non è così. È chiaro anche che se ci sono delle opportunità che la tecnologia offre e se qualcuno le coglie con lo spirito di generare qualità, la qualità può venire fuori. Questo è il problema: prendere questa situazione e fare qualcosa per migliorare lo scambio di informazione. Il portato culturale della Rete è sempre questo: hai trovato un problema? Fai qualcosa per risolverlo, lo puoi fare. È molto più facile poterlo fare. Detto questo è chiaro che la superficialità è sostenuta non solo dalla Rete ma, per esempio, da una certa televisione – non si vede perché negarlo.
Dunque non è qualcosa di intrinseco al mezzo, come si legge tra le righe del pensiero di questi autori…
Non è assolutamente intrinseco al mezzo. Se si guarda la differenza tra il modello di Wikipedia e il modello di Facebook si vede che il modello di Facebook è di più immediata azione-reazione delle singole persone che si connettono e si esprimono cercando essenzialmente di sviluppare la loro figura digitale, mentre su Wikipedia c’è un progetto collettivo ma le persone non appaiono, e ogni persona contribuisce al progetto collettivo. Tutte e due hanno avuto enorme successo e molta energia. L’una va nella direzione di generare un mondo di comunicazioni veloci che in parte hanno qualità in parte non ce l’hanno, l’altra va nella direzione di costruire un sapere strutturato, che dura, che in alcune parti ha qualità in altre non ce l’ha. Quale è la conclusione di tutto questo? Non è la tecnologia che risolve i problemi, ma il progetto, la metafora costruttiva di qualunque soluzione all’informazione ci proponiamo. Dunque per tutte quelle situazioni in cui individuiamo che manca qualcosa, che c’è qualcosa che si potrebbe fare meglio, la reazione è: facciamola.
Da ultimo passiamo al tema del diritto all’oblio. Lei ha più paura di una Rete che non dimentica – secondo il monito di Viktor Mayer Schönberger – o di una Rete che ricorda soltanto ciò che i suoi utenti desiderano sia ricordato?
Bisogna guardare quello che succede effettivamente: la Rete è capace di ricordare tutto, ma non necessariamente di conservare bene tutto. Ero di recente a un convegno che si intitolava “Su quali documenti studieranno la nostra società gli storici nel 2060”. Questo ha un valore, un senso, una importanza di conservazione e dà perlomeno una strategia a mondi di conoscenza come le biblioteche, i musei, gli archivi che sembrano in questa società un pochino messe di lato. Questa cultura della conservazione è una cultura da sviluppare nel nuovo ambito tecnologico. All’interno dei social media nei quali ciascuno sviluppa la sua presenza digitale ciascuno vuole poter sviluppare anche la sua assenza digitale. Io credo che, per come sono messe le cose adesso, sia difficile ottenerla cercando una tecnologia che risolva questo problema di per sé. Credo sia molto importante che le persone sappiano che la privacy o il diritto all’oblio dipendono dalla consapevolezza con cui usano questi strumenti.
Non c’è il rischio, ipotizzato da Schönberger in Delete, di finire in una società che si autocensura?
L’autocensura c’è sempre stata: io ho sempre raccontato i fatti miei solo ai miei veri amici, e agli altri no. C’è una dimensione pubblica e c’è una dimensione privata. Il problema è che queste tecnologie sembrano dimensione privata mentre sono dimensione pubblica. E quindi dobbiamo semplicemente imparare. Sono appena nate. Una società non è capace di interpretare e digerire in fretta cose così importanti; si pensi ai sedici milioni di persone che in Italia sono su Facebook, e in soli tre anni. Dobbiamo raccontare questa cosa il più possibile in modo che la digestione sia veloce e la gente sia consapevole di cosa sta facendo quando è su Facebook.
fonte: ffwebmagazine.it