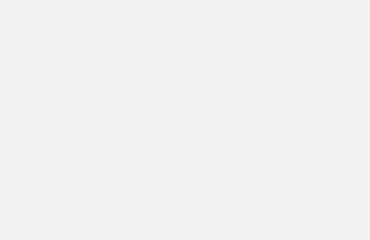di Alberto Mingardi
Fatta salva l’esigenza (per la verità, poco avvertita da chi i giornali li scrive e evidentemente anche da chi li legge) di accertare i fatti prima di emettere un giudizio, il quadro che emerge dalle inchieste di Firenze e di Milano è sconfortante. Sconfortanti le accuse, sconfortanti le dinamiche d’interazione fra magistratura e media, sconfortante la risposta della politica. Guido Bertolaso è l’unico ad uscirne paradossalmente ferito ma bene, senza svicolare dal confronto, senza scrollarsi di dosso le sue responsabilità.
Il problema, a monte, è che vicende come quelle venute alla luce in questi giorni riattivano riflessi condizionati, nell’opinione pubblica e nella “classe dirigente” del Paese. Se non da che mondo è mondo almeno da che l’Italia è l’Italia, le persone “che contano” costruiscono la propria identità sulla presunzione di essere meglio del resto di noi. Gli scandali, i latrocini, la corruzione che segnano tutta la storia d’Italia dall’unificazione ad oggi raccontano questo eterno rimpallo fra moralisti e “praticoni”. La prassi dell’uso dello Stato ai propri fini, la teoria di un “senso dello Stato” artificiale e posticcio. Ci sono culture politiche in Italia che fanno della propria impotenza un senso di distinzione. Perennemente tese verso il rinnovamento del Paese, si rallegrano segretamente della sua incapacità di rinnovarsi. Corruzione e moralismo sono elementi costitutivi dell’Italia così com’è, e del dibattito pubblico. La convinzione di essere “un’altra Italia” è utilissima ad evitarsi la fatica di impegnarsi davvero in quella che c’è. Certi che il meno peggio sia nemico del bene, i “migliori” non sono mai scesi dall’Aventino.
C’è un altro pezzo di classe dirigente, che costruisce identità non sull’avere un’idea del Paese ma proprio sul non avercela – condizione apparentemente indispensabile, per “gestirlo”, il Paese. Siamo sempre al “governare gli italiani non è impossibile, è inutile”. Sottinteso: e allora tanto vale godersi la festa. Il risultato della perversa amalgama di queste due culture è l’Italia che abbiamo sotto gli occhi. Un Paese in cui le leggi sono scritte dai francescani ma vengono applicate dai casalesi, dove tutto è peccato però si fa ampio ricorso alla confessione. E proprio per la tensione fra queste due culture, anziché “semplificare” regole e norme, abbiamo imparato ad aggirarle. Con la corruzione – o allargando a dismisura il concetto di “emergenza”, è dopotutto un dettaglio. Qual è il grande non detto, in questa situazione? È l’economia di relazione, che s’innerva in questa attività di lobby spiccia e laterale, fatta di escort e proiezioni di ricatti, di appalti in famiglia e società eterodirette dal Palazzo.
Ciò che è anomalo non è il fatto che le classi dirigenti si parlino, che alti giudici diano del tu a degli imprenditori, che esistano robusti circuiti relazionali. È così in tutto il mondo: ovunque la parte “che conta” della società fa le stesse scuole, legge gli stessi giornali e gli stessi libri, condivide una storia. La “porta girevole” esiste e ruota a velocità ancora più veloce nei Paesi anglosassoni, dove è piuttosto comune che fra accademia, finanza, impresa, grandi fondazioni e politica si trovino a ricoprire posizioni intercambiabili. Quello che è intrinsecamente diverso è il modo in cui i conflitti d’interesse trovano soluzione.
E questo modo così diverso non passa attraverso l’iper-regolazione dei comportamenti, o attraverso la moltiplicazione dei codici etici. Passa per un’idea diversa del rapporto fra Stato e mercato. Per una linea divisoria limpida, chiara, che non impedisce che le stesse persone possano trovarsi talvolta di qua e talvolta di là, ma cambia il paesaggio morale in cui si muovono.
L’“a Fra’, che te serve” c’è dappertutto – quello che cambia è ciò che può restituire, in cambio, il politico, dall’altra parte della scrivania. Ci sono più lobbisti a Washington che a Roma. Ma il lobbying a Washington è un’attività trasparente, un gioco con regole chiare, che avviene sotto gli occhi di tutti e che richiede qualche sforzo in più rispetto al “presentarti quella persona”. Per Kennedy, il buon lobbista era quello capace di spiegare in dieci minuti un problema che il suo staff ci avrebbe messo ore e ore per comprendere. Spiegare un problema: non semplicemente stornare numeri di telefono, veder gente e fare cose.
Le relazioni esistono dappertutto, e ovunque sono importanti. Ma non sono, non possono essere, l’unico appiglio su cui costruire una carriera. Quanti perfetti cretini conosciamo, che in Italia occupano una posizione apicale soltanto perché testimoniano il potere relazionale di un altro essere umano? Potere relazionale la cui più sfacciata e muscolare manifestazione è sempre imporre un generale idiota. Fregandosene di come andrà poi la guerra. Questa opacità diffusa, questo lobbismo d’accatto, non sono solo l’habitat naturale dei praticoni. Sono anche il risultato delle prediche dei moralisti. I moralisti vogliono che lo Stato sia tutto, e la società nulla. Che l’interesse personale sia dichiarato illegale a norma di legge, per fare degli italiani un popolo di santi. Sono i moralisti che hanno costruito le alcove dei peccatori. Se lo Stato può fare tutto, perché dovrebbe limitare gli “aiutini”?
Ripensare la nostra cultura pubblica non significa lamentarsi che le mezze stagioni non ci sono può, invocare sanzioni per i partiti che si tengono in pancia i corruttori, o nuove regole. L’unica cosa che servirebbe davvero è la separazione fra Stato ed economia. Ma lo spirito dei tempi soffia in tutt’altra direzione.
fonte: Il Riformista