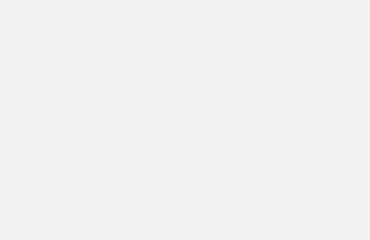di Susanna Tamaro
Viviamo in tempi di assolute certezze e di pochi dubbi. Tempi in cui non sembra esserci spazio per le inquietudini, le malinconie, i sentimenti più sottilmente umani che sono alla base di tanta letteratura che ci ha formato e fatto crescere. Alla cultura si è sostituita l’informazione, la denuncia, il consumo, la polemica. Niente sedimenta, tutto scorre. E così mi sono trovata a riflettere sul significato e l’origine della parola ‘cultura’. Etimologicamente, alla base della parola, c’è la radice indoeuropea kwel, il cui significato è quello di produrre un movimento circolare. Nel passaggio al latino è diventato ‘colere’, coltivare. Coltivare, appunto.
Quest’anno, per la prima volta, non ho coltivato i campi davanti a casa perché, ormai, anche per chi è coltivatore diretto, lavorare la terra è diventata un’impresa totalmente fallimentare. Il periodo natalizio è stato contrassegnato prima da neve e ghiaccio, poi da piogge torrenziali che hanno dilavato la terra, tracciando solchi grandi quasi come trincee sui terreni in pendenza. Se avessi seminato, ho pensato con sollievo, i fragili steli sarebbero stati trascinati a valle, lasciando, al tempo della crescita, il desolato spettacolo di grandi zone spoglie senza vegetazione. Ma questo sollievo è stato di breve durata, perché, in realtà, vedere i campi incolti suscita in me un dolore e una tristezza difficilmente cancellabili. E’ un fenomeno in sempre maggior espansione, purtroppo, basta avere lo sguardo un po’ attento per rendersi conto della modificazione del paesaggio: soprattutto nelle zone collinari e montane, dove una volta si stendevano vasti campi di orzo e di grano, ora non ci sono che le sagome scure di rovi o brulli pascoli disseminati di pecore. Una sofferenza ancora più grande provoca in me la frutta lasciata a marcire sugli alberi. La natura ci offre i suoi doni e noi voltiamo la testa dall’altra parte. No grazie, siete troppi, non sappiamo che farcene. Succede sempre più spesso. Dalle mie parti con gli ulivi, i ciliegi, al sud con gli aranci, i mandarini, perché ormai per un coltivatore – in balia di folli leggi di mercato europee e senza più l’aiuto di una grande famiglia in grado di collaborare alla raccolta – il prezzo del prodotto finale è troppo basso per riuscire a rientrare nelle spese. Ne sono testimonianza indiretta anche i tristi fatti di Rosarno, dove nonostante la grande offerta di manodopera in nero, come ha testimoniato il vicepresidente di Confagricoltura della provincia di Reggio Calabria, quest’anno verranno lasciati marcire sugli alberi ottocentomila quintali di agrumi.
C’è qualcosa di terribilmente inquietante in questo rifiutare i frutti, nel non poter più coltivare i campi. In un mondo in cui il cibo è un problema per milioni di persone, fa male al cuore vedere un tale inconcepibile spreco, ma il turbamento più profondo viene dalla consapevolezza che si sia incrinato il rapporto primario dell’uomo con la sua natura e con la natura che lo circonda. La civiltà, così come noi la conosciamo, è nata con l’agricoltura. Le tribù dei cacciatori nomadi non avevano un’idea precisa del tempo. Cacciavano, consumavano – dato che non si poteva conservare – e tornavano a cacciare. L’irrompere dell’agricoltura ha portato la concezione della circolarità del tempo, kwel, e la consapevolezza che il lavoro è la via per renderlo produttivo. Per coltivare la terra, bisogna conoscere il passato, vedere il presente e immaginare il futuro, sapendo che ogni nostro gesto potrà produrre nuova vita, nuova fertilità. Per rendere fecondo il terreno, è necessario sapere osservare con molta attenzione, saper ascoltare, sapere leggere i legami chiari tra le cose e intuire quelli meno chiari, bisogna essere curiosi, provare, sperimentare, sforzarsi, consapevoli che l’impegno non sempre sarà ripagato dal successo. Si deve soprattutto amare e credere nella vita, perché non si coltiva solo nutrimento, ma qualcosa di molto più grande, che è l’idea di un futuro in cui le generazioni si susseguono.
Col tempo, poi, questa capacità si è espansa in altri campi del vivere umano. Dall’idea di coltivare la terra si è passati all’idea di coltivare la propria interiorità, i propri talenti, i rapporti. La ‘cultura’ della mente – la cultura che nasce dai libri, dall’arte, dalla spiritualità e che ha creato la straordinaria ricchezza della nostra civiltà –
non richiede attitudini molto diverse dalla ‘coltura’ del campi: senso del passato, del presente e del futuro, saper creare legami, essere spinti a crearne sempre di nuovi sulla base di un’insaziabile curiosità e coltivare il dubbio come costante fattore di crescita.
Guardandomi intorno, mi domando: siamo ancora una società che conserva al suo interno il senso profondo del coltivare o stiamo in qualche modo progredendo/regredendo verso una nuova forma di nomadismo tribale, dove l’idea del tempo e della costruzione del tempo è totalmente assente? Si catturano immagini, opinioni, polemiche, indignazioni, le si consumano, e subito, con un’ansia bulimica, si riparte alla ricerca di altre immagini, altre opinioni, altre polemiche, altre indignazioni da consumare. In una tale frenetica frantumazione del pensiero, il sapere non potrà che essere superficiale e privo di radici; e se è privo di radici, è incapace di assorbire il nutrimento, che, nell’ambito della cultura, significa riuscire a cogliere connessioni profonde, conoscere il passato ed essere aperti e vigili nel presente senza avere pregiudizi, vuol dire vivere la curiosità e il desiderio della scoperta come forze fondanti dell’essere umano. Una persona che coltiva – e che si coltiva – non è mai manipolabile ed è sempre lontana dalle ottuse tempeste dei fanatismi.
La nuova tribalità verso cui ci spinge il mondo contemporaneo rischia, alla fine, di essere vittima delle stesse rigidità delle tribalità primitive. Al posto del dubbio, si professano unicamente certezze, destinate a scontrarsi di continuo con altre certezze di segno opposto, senza possibilità di vero dialogo. E l’assenza di dialogo è spesso presagio di tempi oscuri. Anche se può sembrare arcaico e lontano, il mondo naturale che ci circonda è lo specchio della società degli uomini e una società come la nostra che, per le sue leggi economiche, costringe ad abbandonare i campi in balia dei rovi e la frutta a marcire sugli alberi, è una società che ha smesso da tempo di coltivare il senso della vita e culla dentro di sé il germe dell’autodistruzione.
fonte: Corriere della sera, 27 gennaio 2010