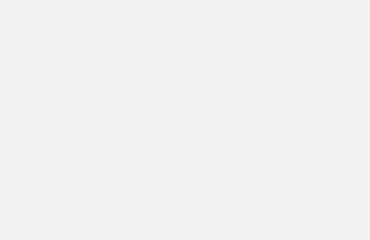di Massimo Gaggi
I ragazzi «nati digitali» sviluppano abilità intellettuali (e biologiche) diverse. Così le tecnologie «ricablano» il nostro cervello e disegnano un’altra specie.
Alla fine qualche dubbio è venuto perfino a Eric Schmidt. Il capo di Google, la società che più di qualunque altra incarna la rivoluzione culturale imposta dalle nuove tecnologie, è ammirato dalla brillantezza e dalle capacità lavorativa dei ragazzi della Internet generation, ma poi ammette che i «nati digitali leggeranno molti meno libri e giornali, cosa che finirà per incidere sui loro meccanismi di apprendimento». Avranno un rapporto diverso con la conoscenza, «ma nessuno sa per ora quale», rifletteva qualche giorno fa in un seminario del Forum di Davos questo manager diviso tra la sua natura di cinquantenne legato alla «civiltà della stampa» e il ruolo di gestore dell’ azienda-totem dei giovani cresciuti nell’ era del Web. In realtà, però, neuroscienziati e studiosi della Rete si stanno sforzando da tempo di misurare l’impatto delle tecnologie digitali sulla mente umana e soprattutto sul comportamento dei giovani nati e cresciuti nell’ era dell’ information technology. Come ho riferito in una breve nota di qualche giorno fa, proprio durante gli incontri di Davos alcuni di loro hanno spiegato che il multitasking dei nostri figli, ormai abituati all’uso simultaneo di più strumenti elettronici, non va demonizzato. È un processo ineluttabile che sta acquisendo le caratteristiche di un vero e proprio cambiamento antropologico: il passaggio dall’homo sapiens all’homo zappiens. I ragazzi born digital svilupperebbero, insomma, abilità mentali diverse: dalla capacità di pensare in modo non sequenziale e di individuare gli elementi essenziali in un magma di informazioni, alla tendenza a sostituire il bagaglio della conoscenza nozionistica con l’abilità nell’uso dei motori di ricerca, fino alla pretesa di dare dignità culturale anche al «copia e incolla». Sono le visioni di personaggi come Adrian Cheok, un neuroscienziato che insegna in Giappone e a Singapore, o di computer scientists e studiosi della comunicazione come Alex Pentland del Mit di Boston o Takeshi Natsuno dell’ Università di Yokohama, per i quali la capacità dei giovani di gestire il multitasking si sarebbe ormai tradotta anche in una differenza rilevabile clinicamente: le risonanze magnetiche che evidenziano lievi modificazioni della corteccia cerebrale nei lobi frontali dei «nati digitali». Tesi abbastanza recenti, legate ai risultati di ricerche mediche dell’ estate scorsa. Ancora pochi anni fa il biologo molecolare John Medina sosteneva nel suo saggio Brain Rules che «il cervello è una struttura sequenziale, fatta per gestire un processo alla volta. Imporgli il multitasking è come infilare il piede destro nella scarpa sinistra». E Jordan Grafman, neuroscienziato del National Institute for Health, ancora pochi mesi fa avvertiva che col multitasking si fanno più errori e si è meno capaci di andare in profondità sugli argomenti. Il rischio, oggi, è quello di essere travolti dagli entusiasti del cambiamento come il futurologo Don Tapiscott, che nel suo bestseller Growing Up Digital analizza i risultati dei test condotti su migliaia di giovani americani, concludendo che cultura digitale e multitasking hanno solo migliorato la loro consapevolezza sociale e la capacità di assorbire nozioni apprese da fonti diverse. Chi, come il saggista tedesco Frank Schirrmacher, paventa, invece, l’emergere di un fenomeno di demenza digitale di massa indotto da problemi di memoria e concentrazione, viene liquidato come un nostalgico di un’era in cui l’unità di misura del multitasking era Gerald Ford, il presidente americano degli anni Settanta che cadeva spesso perché incapace, secondo una celebre battuta, di fare due cose insieme: scendere le scalette dell’aereo tenendo un ombrello in mano. La cavalcata dei profeti del «nuovo che avanza» è implacabile: Howard Rheingold, studioso della cybercultura delle comunità virtuali, è convinto che i giovanissimi che oramai crescono non solo senza giornali ma anche senza tasti – si fa tutto sui «touchscreen» tipo iPhone – rappresentino le avanguardie di una nuova tappa dell’evoluzione umana: chi digita per ore a grande velocità su un telefonino sviluppa intrecci neuronali più complessi e ricchi di chi è abituato al ritmo più blando di una tastiera. Non sembra più fantascienza la previsione del neuroscienziato Bill Joy, che dieci anni fa aveva scritto sulla rivista «Wired» che le tecnologie digitali, con la loro capacità di «ricablare la mente», avrebbero disegnato una nuova specie umana dotata di capacità di resistenza superiori rispetto all’homo sapiens. Ma superiori in cosa? Va bene l’homo zappiens del professor Cheok o di Wim Veen dell’ Università di Delft, il primo a usare, tre anni fa, questa espressione per indicare lo sviluppo di un nuovo «approccio non lineare al pensiero e al lavoro». Va bene lo «zapping» dei ragazzi che osserviamo preoccupati e ammirati mentre si scambiano messaggi con i loro amici, guardano la tv, parlano con noi e conducono un videogioco, tutto nella stessa unità di tempo. Tutto utile (anche il videogioco che, dicono, migliora i riflessi e sviluppa nuove «competenze iconografiche») a reagire più rapidamente agli stimoli, a migliorare i processi collaborativi, anche se questo significa spesso chiudersi nella logica delle tribù e in un tipo di socializzazione distorta dalle macchine. A Davos ho fatto ridere un’intera platea quando, davanti a questa rappresentazione del futuro, ho chiesto: «Ho un figlio di 12 anni che legge romanzi storici. Mi devo preoccupare?». Preso alla sprovvista, Cheok ha ammesso che nei processi in atto ci sono cose che si guadagnano e cose che si perdono, come la capacità di approfondire e pensare criticamente. Tutto ciò, ha aggiunto, è però iniziato con la tv, non con il computer. Ci stiamo, dunque, ponendo quesiti fuori tempo massimo? Non la pensano così il raffinato tecnologo Jaron Lanier, che in un recente saggio demolisce molti luoghi comuni sulla cultura di Internet ed evidenzia la pericolosità di alcuni suoi processi involutivi, o Nicholas Carr, lo studioso della comunicazione che un anno e mezzo fa ha aperto il dibattito con un coraggioso saggio pubblicato da «The Atlantic» («Google ci rende stupidi?») e che da allora non ha mollato la presa. Intanto negli Usa la Edge Foundation, il club degli intellettuali della scienza e della filosofia che cercano un nuovo umanesimo, ha deciso di concentrarsi, quest’ anno, su un solo quesito: «In che modo Internet sta cambiando il tuo modo di pensare?».
Il pensiero dell’uomo alla prova di Internet.
Diversi libri e articoli si occupano del rapporto tra le tecnologie digitali e la psicologia, specie quella infantile. Ad Anna Oliverio Ferraris si devono il saggio «Chi manipola la tua mente» (Mursia, pp. 169, 12) e l’articolo «Baby Tv», sulla rivista «Psicologia contemporanea» del gennaio 2010. Un forte allarme viene dal guru dei new media Jaron Lanier, nel libro «You Are Not a Gadget», (Knopf, pp. 224, $ 24,95) e da Madeleine Bunting, autrice dell’ articolo «Undivided attention», su «The Guardian» dell’11 gennaio scorso. Sull’argomento si era già soffermato Tomás Maldonado nei libri «Memoria e conoscenza» (pp. 308, 20) e «Reale e virtuale» (pp. 186, 18.50 ), editi da Feltrinelli. Il venir meno della vita sociale è denunciato inoltre da John T. Cacioppo e William Patrick nel volume «Solitudine. L’essere umano e il bisogno dell’ altro» (Il Saggiatore, pp. 332, 18.59), così come da Robert D. Putnam in «Capitale sociale e individualismo» (Il Mulino, pp. 504, 36). Da segnalare infine i lavori di due filosofi italiani: Umberto Galimberti, «I miti del nostro tempo» (Feltrinelli, pp. 406, 19); Giulio Giorello, «Introduzione alla filosofia della scienza» (Bompiani, pp. 445, 18).
fonte: corriere.it – 7 febbraio 2010