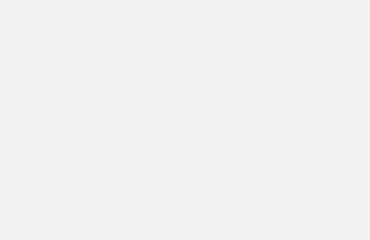Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman riuniti in una stanza arredata con totem e altri oggetti indiani. I Chicago Bulls raccolti intorno al loro coach, Phil Jackson, che legge loro brani dal “Libro della giungla” di Rudyard Kipling per preparare la squadra alla partita. Una frase del romanzo ricorre più spesso: “La forza del lupo è il branco, e la forza del branco è il lupo”. Strane coincidenze accadono. “E’ uno dei miei libri preferiti”, commenta Julio Velasco (il plurivincitore con l’ItalVolley, oggi all’Inter, dopo il ruolo di direttore generale nella Lazio di Sergio Cragnotti), “va però detto che quando il lupo diventa vecchio, e non è più in grado di cacciare, il branco lo uccide. Questo è un po’ quello che succede a tutti i leader“.
Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman riuniti in una stanza arredata con totem e altri oggetti indiani. I Chicago Bulls raccolti intorno al loro coach, Phil Jackson, che legge loro brani dal “Libro della giungla” di Rudyard Kipling per preparare la squadra alla partita. Una frase del romanzo ricorre più spesso: “La forza del lupo è il branco, e la forza del branco è il lupo”. Strane coincidenze accadono. “E’ uno dei miei libri preferiti”, commenta Julio Velasco (il plurivincitore con l’ItalVolley, oggi all’Inter, dopo il ruolo di direttore generale nella Lazio di Sergio Cragnotti), “va però detto che quando il lupo diventa vecchio, e non è più in grado di cacciare, il branco lo uccide. Questo è un po’ quello che succede a tutti i leader“.
Perché secondo lei il mondo imprenditoriale parla sempre più spesso di gioco di squadra?
“Per una serie di fattori che stanno coinvolgendo la nostra società: per la grande competitività, per la crescente complessità, per la concentrazione a livello imprenditoriale, e infine, per la globalizzazione”.
Come valuta il mondo aziendale sotto il profilo dello spirito di squadra?
“Mi sembra di capire che nella nostra società, in azienda, la cultura di squadra non sia molto diffusa. Tutti insistono a voler parlare di gioco di squadra, che è visto come un imperativo morale da raggiungere. Ciò equivale a dire: dobbiamo essere dei bravi ragazzi, dobbiamo avere spirito di squadra. Questo è positivo ma non sufficiente. Un mero concetto di solidarietà: tutti per la causa“.
Ma allora il gioco di squadra è imprescindibile?
“E’ necessario inquadrare il problema. Io non sono d’accordo con l’affermazione che senza la squadra non si fa nulla. Il mondo imprenditoriale è pieno di uomini che da soli, usando gli altri come pedine operative, hanno fatto grandi cose. Ritengo però che gli affari, come tante altre attività, in una società che si sta sempre più globalizzando, siano diventati sempre più complessi, più vasti. Come conseguenza anche se si ha il fuoriclasse, imprenditore o giocatore che sia, si farà sempre più fatica. Ergo, il gioco di squadra comincia ad essere una necessità. E non a caso sta divenendo un concetto di cui si parla molto nelle aziende”.
Quale motivazione, in un mondo sempre più orientato all’individualismo, spinge a creare un gioco di squadra?
“Essenzialmente perché conviene a chi ne fa parte. Anche se ragiona da egoista. Per la stessa essenza del gioco di squadra: la tattica. La tecnica è solamente lo strumento. Un buon sistema tattico permette di mettere in evidenza i miei pregi e nascondere i miei difetti, e, contemporaneamente, sottolineare i difetti dell’avversario e neutralizzare i suoi pregi”.
E’ la tattica, allora, il valore aggiunto del giocare in una squadra?
“Esattamente, perché anche se un giocatore è bravissimo c’è sempre qualcosa in cui non è molto abile. E tramite il gioco collettivo si riesce a far emergere il meglio di ognuno, sopperendo ai suoi difetti con le doti di un altro. Un gioco di squadra che non faccia questo applica una tattica sbagliata. Inoltre continuando a tarpare i pregi di un individuo, alla lunga, questi si stacca dalla squadra. In un club sportivo può essere sostituito, ma in un’azienda, dove la mobilità è decisamente più bassa, può diventare un problema serio”.
E come si mantiene un individuo all’interno della squadra?
“Non certo con discorsi moralistici. Servono criteri più utilitaristici e pragmatici: deve intravedere la convenienza dello stare nel gioco di squadra, traendo i maggiori benefici personali giocando insieme a compagni che nascondano i suoi difetti ed esaltino invece i suoi pregi”.
Da dove inizia, quindi, la costruzione di una squadra?
“Dall’avere chiaro l’obiettivo. La seconda è di avere un gioco ben delineato, conosciuto da tutti“.
Che cosa significa?
“Significa che la metodologia, lo stile di lavoro e di gioco, devono essere chiari a tutti, e non soltanto al capo. Molti concepiscono il gioco di squadra come: “io penso, loro eseguono. E chi non esegue non possiede spirito di squadra”. Le vere squadre non sono così. Il ruolo dell’allenatore consiste nel saper costruire un gioco in collaborazione con i giocatori“.
Ed ecco il ruolo dell’allenatore. “Uno non è un grande allenatore quando fa muovere un giocatore secondo le proprie intenzioni, ma quando insegna ai giocatori a muoversi per conto loro. L’ideale assoluto, che come tale non è mai raggiungibile, viene nel momento in cui l’allenatore non ha più nulla da dire, perché i giocatori sanno già tutto quello che c’è da sapere. Tutti devono conoscere, oltre alla tecnica, come si gioca, la tattica, insomma”.
La figura dell’allenatore è quindi assimilabile a quella di un capo?
“E’ indubbiamente un ruolo di comando. Deve essere in grado di assumersi sulle proprie spalle i rischi. La tattica deve essere condivisa da tutti, anche tramite un contraddittorio. Se non c’è accordo tra tutti, cosa si fa? Qui entra in gioco il capo: ebbene, decide lui, perché non si può vivere nel conflitto. Il capo si assume le sue responsabilità, cercando di sbagliare il meno possibile. Un margine di errore esisterà ovviamente sempre, l’essenziale è esplicitarlo ben chiaro in precedenza”.
Squadra e gruppo, non sono la stessa cosa.
“No, e non vanno confusi. Il gruppo è l’elemento alla base della squadra. Il gruppo si forma svolgendo un’attività in comune: ad esempio, una classe scolastica. Nel gruppo l’individuo ha dei ruoli, ma non ben delineati, attribuitigli spontaneamente dagli altri componenti. Inoltre non c’è un unico leader, perché viene scelto a seconda dell’attività svolta. Il gruppo è un’entità propria: ciò significa che la sua caratteristica non deriva dalla somma delle caratteristiche degli individui che compongono il gruppo, ma bisogna ricercarla nelle dinamiche che si creano al suo interno. E’ necessario verificare come ciascun individuo funziona nel gruppo e non come è fatto, se ha talento, oppure se ha un certo carattere, o se è coerente ad un certo metodo di lavoro”.
Che cosa, allora, caratterizza una squadra rispetto ad un gruppo?
“I ruoli, che devono essere ben definiti. In funzione del tipo di gioco che si vuole fare, della tattica che si intende applicare. E’ inammissibile, ad esempio, che un terzino vada a fare la punta soltanto perché il centravanti non segna. Questo implica accettare anche i limiti, i difetti, gli errori dei compagni. Ciascun giocatore deve avere e rispettare il ruolo assegnatogli dall’allenatore, dal capo, dal vertice”.
Iniziano i problemi per l’allenatore.
“Il capo fa parte dei ruoli prestabiliti, il suo è quello di comandare, istituzionalmente. E’ necessario differenziare tra capo e leader. La leadership si guadagna con il consenso, si deve instaurare un’autorità morale per comandare. Il leader lo stabilisce il gruppo, non ha un ruolo assegnato, ad esempio, da un organigramma. Restando nello sport, ci sono allenatori che non sono leader e che utilizzano quelli che si vengono a creare in modo naturale all’interno del gruppo dei giocatori. Un capo perde la stima della squadra soprattutto quando non rispetta i ruoli altrui, e non quando non è un leader“.
Quando però c’è qualcosa che non funziona è difficile rispettare i ruoli.
“Tutto dipende dal clima creato dal vertice, dai capi, sul modo di interpretare un errore. E’ in caso di difficoltà che si vede se c’è davvero lo spirito di squadra. Quando le cose vanno bene è semplice rispettare i ruoli, quando invece vanno male si innesca un meccanismo basato sul tentativo di dimostrare la propria innocenza, tra mille alibi e giustificazioni, e la colpevolezza degli altri. Il problema di fondo è che l’errore viene visto come una dimostrazione d’incapacità e non come degli strumenti d’apprendimento“.
Ha parlato spesso di cultura degli alibi.
“L’alibi, oltre a distruggere l’armonia, impedisce di progredire, di imparare. E’ una situazione che nella mia esperienza ho trovato ovunque. L’errore segnala la necessità di apportare modifiche, la scusa, invece, impedisce di mettere in moto delle risorse che, a volte, non si sa neppure di avere”.
Nel romanzo ‘I Promessi Sposi’ di Alessandro Manzoni, Don Abbondio si giustifica dicendo: “Se uno il coraggio non ce l’ha, non se lo può dare”. Quanto contano le motivazioni?
“Affinché i ruoli, il gruppo, la squadra funzionino è chiaro che la motivazione è un elemento fondamentale. Che non deve essere astratta, culturale o morale. Ci sono tre tipi di motivazione: quella di base, quella economica e quella della sfida”.
In che cosa consiste la motivazione di base?
“Fare ciò che piace. Di conseguenza, quando si costruiscono le squadre, bisogna scegliere gente a cui piace quel ruolo. In ogni modo è possibile migliorare le condizioni di lavoro, l’ambiente (ad esempio un ufficio accogliente, la comodità per raggiungere il posto di lavoro), concedere gratificazioni, al fine di rendere più soddisfatti di ciò che si svolge. In questo gli americani sono dei maestri, per quanto li riguarda: meglio si vive, più si rende. In Italia c’è un disinteresse assoluto per questi argomenti. Un buon allenatore deve cercare di mettere, se può, un giocatore nel posto in cui sa che gli piace stare”.
La motivazione economica, invece.
“E’ molto importante, i premi, le incentivazioni sono un ottimo stimolo. Ma diventa negativa quando si richiede di far gioco di squadra e poi il guadagno va soltanto alla proprietà”.
Lei ha parlato di sfida…
“Questa motivazione per me assume un ruolo fondamentale, non tanto riguardo agli impegni quotidiani, quanto ai grandi compiti. Credo che la gente, soprattutto in una società decisamente omologata come l’attuale, abbia bisogno delle emozioni, di sentirsi parte di qualcosa che va al di là della routine di tutti i giorni, di competere per un’impresa straordinaria. Questo a maggior ragione nel mondo del lavoro”.
Come si fa ad avere la mentalità vincente?
“A questa domanda io rispondo sempre con un paradosso: vincendo! Il problema è: come faccio a vincere? Esistono tre tipologie. La prima vittoria è quella contro i propri limiti e i difetti. La funzione del capo è fondamentale: deve porre obiettivi facilmente raggiungibili, in maniera da far fare un passo alla volta e, soprattutto, deve dare aiutare a risolvere i difetti. E poi superare le difficoltà è un allenamento. Questa è la seconda tipologia di vittoria. Le difficoltà non devono più essere viste come un qualcosa che mi impedisce di fare, ma come la possibilità di allenarmi a superarle”.
E la terza vittoria?
“E’ quella contro gli avversari, i concorrenti. Che va programmata: da una parte affrontando avversari che siano alla mia portata, dall’altra, contemporaneamente, confrontandomi contro i migliori, anche se perdo. Questo mi serve per stabilire un punto di riferimento alto. A volte si impara di più perdendo contro un avversario forte piuttosto che vincendo da uno debole”.
fonte: stageup.com