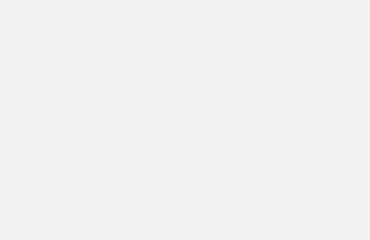di Carlo Carboni
Con la Seconda Repubblica i ceti politici ristretti locali e i cartelli territoriali dei principali gruppi d’interesse hanno “messo sotto”, come si dice in gergo sportivo, i loro interlocutori nazionali. Il localismo sta vincendo la sua battaglia sul ceto politico nazionale.
Siamo già nel pieno dell’Italia dei localismi in salsa “inizio nuovo millennio”. Le evidenze di questo trionfo dei ceti politici locali e regionali? L’aumento delle cariche elettive locali in questi ultimi 15 anni, il federalismo fiscale, e, soprattutto, l’esplosione delle problematiche territoriali sul piano sociopolitico: a quella meridionale, si è aggiunto il malessere nel benessere del Nord e, forse, persino una problematica del Centro Italia, dove si è trincerato il centro-sinistra.
Il potere assunto dai mercati politici locali e regionali (ad esempio nella sanità) sul piano nazionale, il prestigio e la notorietà dispensata ad alcuni leader regionali e di grandi città dimostrano che i ceti politici locali e regionali sono pronti a sparigliare un ceto politico nazionale autoreferenziale e distante dal paese. Oggi, in termini di potere misurato in consenso elettorale, per un politico è preferibile essere assessore regionale alle attività produttive piuttosto che deputato in parlamento.
Non parliamo del potere dei sindaci delle grandi città o dei presidenti delle regioni, chiamati governatori e trattati al pari dei leader degli stati regionali di cui la Penisola era composta, come un mosaico istituzionale, in epoca medievale e contemporanea.
Dopo un “breve” tentativo di unificazione durato 150 anni, ora cerchiamo una nuova strada federale e quindi siamo portati a guardare con maggiore attenzione alla formazione di leadership territoriali a valenza nazionale. Siamo perciò di fronte a un processo di generazione del ceto politico nazionale su base locale e regionale, favorito dalla scelta federalista che il paese sta compiendo.
Tra i partiti, chi ha tratto maggior vantaggio da questa tendenza alla rinascita delle comunità locali e regionali è stata la Lega, partito pesante e territoriale. Della tendenza ha fatto il presupposto per promuovere un ricambio del ceto politico nazionale a mezzo del ceto politico locale e regionale: direi, da Maroni in poi (ma non senza incidenti).
Se il numero delle cariche elettive comunali, provinciali e regionali è apparso e appare eccessivo, d’altra parte la sua espansione ha aperto nuove palestre formative per nuovi amministratori. Scartata l’idea di generare in vitro nuovi leader politici, venute meno le vecchie scuole dei grandi partiti di massa, lo scenario formativo politico è diventato striminzito e si limita ad alcune fondazioni politiche, che non sono scuole di partito, ma piuttosto think thank elitari, stretti attorno ad alcune personalità politiche che costituiscono il nerbo dei partiti-etichetta.
Dunque, il ricambio dei ceti politici nazionali con ceti politici che si sono “fatti le ossa” nelle istituzioni territoriali può costituire una modalità credibile per esibire un cursus honorum (che scandiva la carriera politica già in epoca romana), una professionalità politico-amministrativa accreditata. Si pensi ai nuovi leader del nordismo leghista e non solo, ma anche a quelli che stanno attualmente ronzando attorno al partito trasversale del Sud. E nel caso fosse eletto Bersani a segretario del Pd, questo partito sperimenterebbe una leadership emiliana, simbolo del radicamento sociale e della buona amministrazione locale e regionale nelle regioni ex-rosse del Centro Italia.
A suo modo, anche l’elezione di Bersani testimonierebbe l’importanza di esibire oneri e onori conseguiti “in provincia”. Mai tra i comunisti prima e tra i postcomunisti vi era stato un segretario emiliano, della regione a maggior radicamento dei democratici.
Viene perciò da chiedersi se si possa parlare di un “modello Lega” nel ricambio di ceto politico nazionale a mezzo di ceto politico locale e regionale. E soprattutto: questo modello cavalcato dalla Lega sta effettivamente contagiando altre formazioni dei due schieramenti politici, come l’elezione probabile di Bersani a segretario Pd e le spinte alla creazione di un partito del Sud lasciano intendere? Dalle mie ricerche che conduco dal 1992 sulle élite italiane, ricavo che il ceto politico nazionale ha un tasso di ricambio su base quinquennale di circa il 50% e che soprattutto non sono cambiati granché i politici che raccolsero la staffetta del dopo-tangentopoli. Infatti, tra essi, esiste un nocciolo duro (invecchiato), un alto cerchio, di leader politici, un ceto ristretto d’intoccabili, considerato insostituibile (le personalità).
Le ricerche mostrano inoltre che il ceto politico del dopo-tangentopoli si era talmente indebolito da richiedere supplenze di eminenti tecnici e da subire invasioni di altre professionalità, tra le quali le più importanti continuano ad essere quella degli imprenditori e dei giornalisti, a testimonianza della crescente finanziarizzazione e mediatizzazione della politica. Soprattutto, i risultati di ricerca sottolineano che, accanto a queste supplenze professionali, cresce l’importanza sul piano nazionale di esponenti di grandi città e regioni.
In conclusione, da questo ragionamento, confortato dalle ricerche condotte, mi sembra di poter ricavare che effettivamente mentre si sta definendo il mosaico del nostro stato nazionale federale, in parallelo, si stia facendo largo a livello nazionale un ceto politico territoriale che, a differenza della stagione dei sindaci e dei nuovi amministratori sperimentata negli anni 90, oggi ha l’opportunità di scalare direttamente la scena nazionale – senza forti filtri di apparato – e quindi con le sue risorse, personalità e notorietà; potrebbe essere persino candidato a riscrivere quei grandi patti nazionali, di cui si avverte l’assenza dal tramonto di quelli consociativi e neocorporativi della Prima Repubblica. Dunque, il ceto politico nazionale del futuro sarà sempre più specchio del mosaico istituzionale territoriale.
tratto da Il Sole 24 Ore – 2 settembre 2009